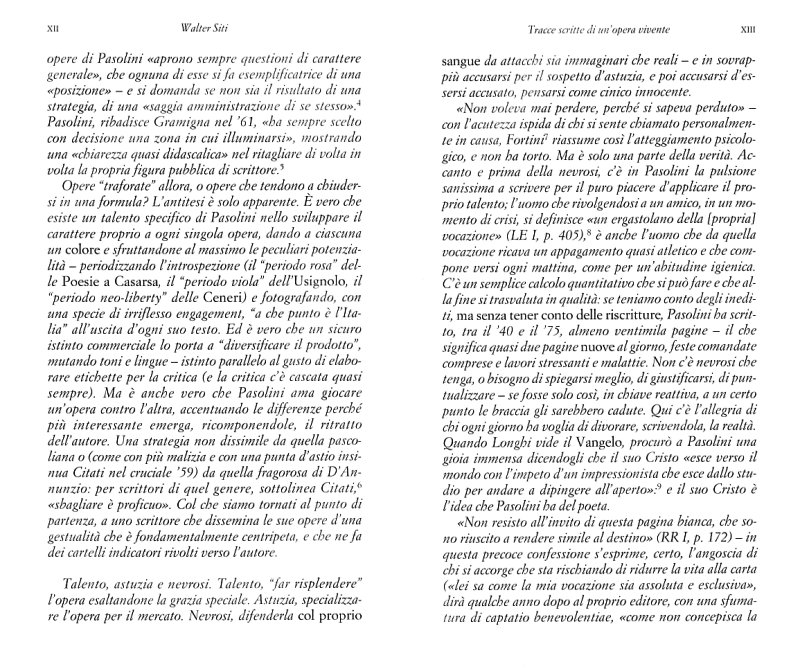"Pagine corsare"
LA SAGGISTICA
«La negra luce». Pier Paolo Pasolini e l’autobiografia
di una «passione recidiva»
di Alessandro Barbato
di una «passione recidiva»
di Alessandro Barbato
«Ah, le mie passioni recidive
costrette a non avere residenza!»
Pier Paolo Pasolini (1964: 31)
Chiunque abbia una certa familiarità con la sterminata bibliografia critica riguardante i diversi aspetti della multiforme produzione di Pier Paolo Pasolini, non può sorvolare su un dato che sembra accomunare un immenso bacino di monografie che, anno dopo anno, si arricchisce di titoli e di contributi provenienti da ambiti disciplinari diversi e, talvolta, anche distanti l’uno dall’altro. Si tratta della pressoché impossibilità ad affrontare qualsiasi aspetto dell’opera dell’autore prescindendo da continui riferimenti biografici ai quali è spesso attribuito il compito di chiarire i perché di una scelta, le motivazioni di un cambio di tecnica o di direzione, i significati di un improvviso ritorno a un tema che sembrava esaurito, le ragioni di un inatteso salto in avanti verso una nuova frontiera della propria espressività artistica.
Esiste, in effetti, una profonda e attiva corrispondenza tra la vita e l’opera di Pier Paolo Pasolini. E se da un lato tale formula potrebbe apparire niente più che il riproporsi di un antico adagio di cui si è spesso nutrita la critica letteraria; dall’altro, nel caso specifico, essa consente di avviare una più profonda analisi della produzione di un artista che, in maniera sempre più determinata, decise quasi di irrompere nei propri lavori con la sua stessa presenza d’intellettuale e di uomo pubblico. Presenza la cui discussa e a tratti scandalosa celebrità - controbilanciata da una solitudine esistenziale dai contorni vittimistici e sacrificali altrettanto esibiti - lentamente pare imporsi anche a discapito della vita intima dell’autore; in una progressiva e problematica sovrapposizione del personaggio alla persona alimentata coscientemente e provocatoriamente da Pasolini stesso.
Per queste ragioni, è proprio dall’insieme delle opere, più ancora che dalle numerose dichiarazioni con le quali Pasolini volle rendere note le sue vicende biografiche, che emerge l’affascinante autoritratto di un autore che sembra aver pazientemente diluito la sua stessa esistenza negli oltre tre decenni che abbraccia la sua produzione.
Tale peculiarità non poteva sfuggire a Walter Siti, curatore dell’edizione delle opere complete dell’autore per i tipi «I meridiani» dell’editore Mondadori, nonché uno dei massimi esperti e conoscitori della produzione pasoliniana. Il titolo del suo lungo saggio di apertura al primo dei dieci volumi che conta l’edizione - Tracce scritte di un’opera vivente (Siti 1998a: XI-XCII) - indirizza sin da subito il lettore sulla specificità di un rapporto, quello tra vita e opera, che in Pasolini più che in altri non può essere trascurato o liquidato in poche battute. Siti sostiene addirittura che «è perbenistico, per uno scrittore del suo tipo, voler separare il personaggio dall’opera - un atteggiamento di purismo accademico, che volesse prendere in esame soltanto la coerenza interna dei testi, virtuosamente prescindendo dai clamori della biografia, finirebbe col tradire i testi stessi, nella cui forma è iscritta l’immagine di chi li ha concepiti, come quei quadri in cui l’autore ha dipinto se stesso nell’atto di dipingere» (ibid.: XXX).
Altrove, riflettendo sul Pasolini narratore, Siti spiega che la scarsa predisposizione dell’autore a plasmare personaggi che siano in qualche modo autonomi rispetto al loro creatore sia da rintracciare «nell’impossibilità di Pasolini di donarsi a un personaggio, cancellandosi», e ciò non «per mancanza di generosità, ma per eccesso di competizione. Pasolini è sempre sulla scena, è con lui che il lettore incessantemente s’identifica, perché lo sente come qualcuno che non ha mai finito di fare i conti con il mondo; è sempre lui che si giustifica, che mostra, che si incanta, che accusa.» (Siti 1998b: XCVIII). La precedente affermazione può agilmente essere applicata ai diversi ambiti in cui si dispiega la creatività pasoliniana: che si tratti dei racconti o delle poesie, della saggistica o del cinema; la continua presenza - quasi ingerenza - dell’autore nelle sue opere; il suo perenne essere presente come centro nevralgico di ciascun verso, periodo o inquadratura - oltre che il suo “presenzialismo” unito a una volontà quasi didascalica nello spiegare e nel difendere ogni sua iniziativa con una vivacità polemica fatta di continui rilanci talvolta seguiti da amare abiure - contribuiscono a imbrigliare in un’unica e densa matassa opera, persona e personaggio.
Da ciò deriva anche la difficoltà dei critici nel separare l’una dall’altra musa espressiva utilizzata dall’autore. La vena poetica s’innerva nel cinema e nella prosa letteraria come se questi fossero il naturale prolungamento, direi anzi il potenziamento, di un’esperienza - quella poetica - elevata al grado di ragione esistenziale oltre che di strumento conoscitivo atto a penetrare il mondo fin nella sua più riposta sostanza (Arecco 1977: 80). Allo stesso modo la prosa artistica dei primi esperimenti narrativi imbeve con il suo stile, e con i suoi motivi ricorrenti, quelle che dovrebbero essere distaccate pagine di critica letteraria dedicate ad altri, ma dove l’autore finisce spesso per parlare di sé (Pasolini 1979). Il linguaggio cinematografico si condensa nei versi delle sillogi poetiche pubblicate in concomitanza con l’uscita di un film nelle sale. Raccolte in cui la poesia stessa tende a divenire prosa magmatica; diario balbettante e incerto in cui, con l’uso dei puntini di sospensione, di parentesi o della dicitura omissis, sono versificate anche le ansie e dubbi di uno scrittore che si muove spesso ai limiti della confessione pubblica e psicologica, solo a tratti sublimata nello spazio letterario di una descrizione paesaggistica, di un movimento proprio o altrui, di un rincorrersi di luci e di voci su uno spiazzo della desolata periferia romana (Pasolini 1964).
Nascono in questo modo generi originali come l’intervista e la polemica in versi, la finta poesia su commissione, il saggio en poète. Oltre che i tanti appunti per opere da farsi che Pasolini inizia a pubblicare, o a realizzare cinematograficamente, nel momento stesso in cui si dedica a sperimentare nuove modalità espressive finendo per appassionarsi al «non finito»: ovvero alla pubblicazione di opere il cui tragitto editoriale o redazionale era rimasto, per diverse ragioni, incompiuto; o al confezionamento di testi che raccolgono diversi tipi di contributi, con tanto di appunti per opere da farsi. Materiali eterogenei che sono offerti al lettore quasi fossero i documenti di un cammino, personale e culturale, sorpreso nell’atto stesso del suo prodursi. Quello che ne scaturisce è una vera e propria restituzione di frammenti che alludono a disegni più vasti, e che devono proprio al loro essere rimasti parte di un insieme più ampio, che in qualche modo li completa, la propria legittimità.
Insieme che non è altro che l’autore stesso. La sua vita - letteraria o reale poco importa considerando quanto sono intrecciate l’una nell’altra, - le sue nevrosi. Le personali aspirazioni - tanto artistiche quanto umane - in cui nuovamente si rispecchiano i dubbi, le convinzioni, le sofferenze intime e i disagi derivati dalle evoluzioni di una società il cui quadro angosciante pare a sua volta immergersi nella vita dell’autore per poi riaffiorare, sotto forma di opera, dalle pulsioni e da un intelletto che nutrono una creatività sempre più polemica e rabbiosa. In tal modo il poeta, l’uomo e il personaggio Pasolini riescono effettivamente a ricongiungersi nell’insieme di una produzione interpretabile anche come una sorta di piccolo «meta-luogo» in cui la storia personale dell’autore incontra quella collettiva di un paese, l’Italia, coinvolto allora in una grande, e per Pasolini innaturale, trasformazione; intersecandosi in un complesso affresco a tinte forti, e gettandosi addosso reciprocamente le luci e le ombre di un’intensa stagione artistica, culturale e politica.
Insieme che non è altro che l’autore stesso. La sua vita - letteraria o reale poco importa considerando quanto sono intrecciate l’una nell’altra, - le sue nevrosi. Le personali aspirazioni - tanto artistiche quanto umane - in cui nuovamente si rispecchiano i dubbi, le convinzioni, le sofferenze intime e i disagi derivati dalle evoluzioni di una società il cui quadro angosciante pare a sua volta immergersi nella vita dell’autore per poi riaffiorare, sotto forma di opera, dalle pulsioni e da un intelletto che nutrono una creatività sempre più polemica e rabbiosa. In tal modo il poeta, l’uomo e il personaggio Pasolini riescono effettivamente a ricongiungersi nell’insieme di una produzione interpretabile anche come una sorta di piccolo «meta-luogo» in cui la storia personale dell’autore incontra quella collettiva di un paese, l’Italia, coinvolto allora in una grande, e per Pasolini innaturale, trasformazione; intersecandosi in un complesso affresco a tinte forti, e gettandosi addosso reciprocamente le luci e le ombre di un’intensa stagione artistica, culturale e politica.
Per queste ragioni è quanto mai arduo occuparsi di Pasolini senza tenere ben presenti la particolare temperie storica in cui era coinvolto, le vicende giudiziarie e sentimentali che lo scossero e che determinarono crisi personali e rigetti, i fatti e gli avvenimenti su cui non mancò mai di esprimere il suo, talvolta esasperato, punto di vista. Ed è anche per questo che, soprattutto a partire dagli anni sessanta, l’intera opera pasoliniana sembra di volta in volta divenire «quel tavolo anatomico su cui è esposto nudo il corpo dell’autore» di cui Siti parla riferendosi alla produzione poetica (Siti 1998a: XLVIII). Un corpo su cui è possibile ritrovare anche le ecchimosi e gli sfregi causati dal vivere, oltre che quelli determinati da una lunga carriera letteraria e cinematografica che, anche grazie alla fioritura degli studi sul tema, sembra sempre di più assumere le vesti di una straordinaria e affascinante autobiografia.
Corpo esposto, occorre aggiungere, non soltanto metaforicamente; ma anche materialmente attraverso una miriade di scatti fotografici che hanno immortalato Pasolini a lavoro sul set di un film così come durante l’appassionata presentazione di un libro. Curioso e sorridente tra i baraccati romani o nel corso di uno dei suoi originali reportage giornalistici; in atteggiamento pensieroso davanti alla macchina per scrivere nella sua abitazione privata oppure in una trattoria, con uno sguardo allegro e scanzonato, mentre mangia in compagnia dei suoi amici e confidenti.
O ancora quelle di Dino Pedriali che lo ritraggono nudo, dietro i vetri offuscati del suo tanto sospirato eremo viterbese: quello che riuscì ad acquistare qualche tempo dopo aver anche versificato su tale desiderio (Pasolini 2003, vol. II: 1288), e che sarebbero dovute servire da documento da inserire nell’immenso romanzo incompiuto - una sorta di summa di tutte le esperienze precedenti, caratterizzato da uno stile fortemente autobiografico - cui lo scrittore lavorava quando la morte lo sorprese (Siciliano 2005: 406-408, I ed. 1978).
Come dimenticare poi quelle - tristemente note - del suo cadavere dilaniato e impastato di terra e sangue pubblicate sui quotidiani all’indomani del suo barbaro assassinio; o quelle altrettanto celebri dei suoi affollatissimi funerali. Non è esagerato affermare che Pasolini è stato tra i letterati più fotografati del novecento; tanto che un’accurata scelta di materiali pubblici e privati è stata alla base di un’originale biografia per immagini che ci restituisce, oltre le pose di un uomo sempre più consapevole della propria dimensione pubblica, anche le atmosfere - sociali e culturali - che l’autore volle attraversare da discusso, ma proprio per questo indiscutibile, protagonista (Pierangeli Barbaro 1999). Forse una poesia, più di ogni altra, esprime appieno il particolare rapporto che intercorre tra la vita e l’opera dell’autore, esteriorizzando anche il suo prevaricante desiderio di gettare, metaforicamente e non, il proprio corpo, e con esso la propria vita e la propria storia, nella lotta che in quegli anni aveva deciso di ingaggiare contro gli spettri di una società che a suo dire, com’è noto, stava rapidamente scivolando verso una cupa barbarie tecnologica e inespressiva.
Si tratta del poemetto Poeta delle ceneri pubblicato postumo sul numero di luglio-dicembre 1980 della rivista «Nuovi Argomenti» a cura di Enzo Siciliano (ora in Pasolini 2003, vol. II: 1261-1288) ma datato 1966. Da una breve nota di Siciliano si apprende che i versi furono scritti durante un soggiorno di Pasolini a New York, e come risposta a una non meglio precisata, forse solo immaginata, richiesta d’intervista da parte di un giornale statunitense. Il titolo originario, racconta Siciliano, sarebbe dovuto essere, con tutta probabilità, Who is me. Il contenuto, come lo stesso titolo previsto lascia intuire, ancora una volta autobiografico. In esso Pasolini ripercorre la sua vita sin dalla sua nascita «in una città piena di portici nel 1922»; rileva con orgoglio narcisistico di dimostrare meno dei quarantaquattro anni che aveva all’epoca; rievoca il dolore causatogli dalla morte prematura del fratello Guido e come lui stesso lo avesse indirizzato verso il tragico destino che lo attendeva tra i monti friulani dove si era aggregato alla lotta partigiana.
Parla poi diffusamente dei suoi genitori: di quanto amasse sua madre, «la cosa più importante della mia vita», e ancora più a lungo dell’inimicizia, a suo dire figlia del destino, che lo opponeva al padre; cui pure aveva dedicato il suo primo libretto di versi: quelle Poesie a Casarsa che il genitore ricevette per posta durante la prigionia in cui era caduto in Kenya nel corso della seconda guerra mondiale. Versi che Pasolini dice di considerare «i miei più belli/ insieme a quelli scritti fino ai ventitré, ventiquattro anni,/ […] nati da quella profonda elegia friulana/ di autolesionista, esibizionista e masturbatore». (ibid.: 1265)
Subito dopo questa lunga incursione nello spazio del familiare e nel sogno giovanile di una vita che fosse pura poesia, ecco che i clamori della cronaca si mescolano a quello che sembrava essere fin lì un tono confidenziale: «Non posso dirvi altre cose/ del mio soggiorno/ in quel paese di temporali e di primule,/[…] s’incaricheranno magari dei giornalisti italiani fascisti…» a raccontare «quella pagina di romanzo» che fu la precipitosa fuga del poeta e di sua madre dai rancori paranoici di un padre sempre più isolato nell’alcolismo e nella sua follia; e il conseguente spezzarsi del cordone ombelicale che lo legava all’amata terra materna (Siciliano 2005: 158-175). Una fuga in treno verso Roma, consumata all’alba che, insieme alla perdita del posto da insegnante che aveva ottenuto presso una scuola media di Valvasone, fu la più immediata conseguenza di una denuncia per corruzione di minore e atti osceni che significò per Pasolini anche la pubblica rivelazione di un’omosessualità fino ad allora vissuta con un continuo contraddirsi di abbandoni e sensi di colpa, come peraltro le poesie e altri scritti del periodo - veri e propri idilli in cui il tempo pare cristallizzarsi nel mito di una giovinezza perfetta e atemporale squarciata soltanto dai frequenti inserti autobiografici - illustrano abbondantemente; oltre che l’inizio di una lunga serie di processi, alcuni palesemente pretestuosi, che lo coinvolsero anche dopo la morte (Betti 1977).
Un’esperienza vissuta come il protagonista di una pagina di romanzo, «l’unica della mia vita:/ per il resto, che volete, / sono vissuto dentro una lirica, come ogni ossesso.» (Pasolini 2003, vol. II: 1265). Vivere dentro una lirica lasciando che la vita stessa divenisse un immenso componimento capace di restituire al poeta un nido caldo e materno dentro il quale trovare riparo e celebrare il mistero e l’intima sacralità dell’esistenza. Allo stesso tempo però, così concepita, la poesia non può non apparire simile a una membrana che separa l’autore da una realtà che questi non riesce mai a possedere completamente se non attraverso lo scarto di un filtro poetico che, alla lunga, si rivela inadeguato a pacificare le contraddizioni e gli spasmi quotidianamente riversati in tumultuosi fiumi di versi in lingua e in dialetto. Anche per questo, già durante la giovinezza, Pasolini oltre alla poesia, adotta un particolare stile narrativo, che presto avrebbe invaso la poesia stessa, che gli consente di rispondere a un’esigenza di «sincerità» sempre più impellente: «mi sembra ormai considerazione di ordine inferiore anche l’intendere la poesia in friulano come un limbo consentito a chi voglia sfuggire a un impulso morale di troppa e assoluta sincerità.» (Pasolini 1988: 209).
Un’ossessione - quella per la sincerità - che ben presto si lega al desiderio di essere presente all’interno di una realtà da cui il poeta si sente invece fatalmente e drammaticamente escluso; e che più tardi avrebbe condotto Pasolini a filosofare sul cinema come dello strumento privilegiato per tentare di catturare la lingua primigenia - la lingua della realtà appunto - che scaturisce da un fluire di uomini, oggetti, luci, voci, sentimenti e odori (Pasolini 1972: 202-230). Dalle passioni e dalle ideologie che sarebbero allo stesso modo divenute la materia vivente di un ininterrotto poema bio-bibliografico che l’autore avrebbe continuato ad aggiornare fino alla fine, senza escludervi abbagli e sconfitte, le sue così come quelle della poesia stessa.
Di questo senso di esclusione, precedente anche alla consapevolezza della propria diversità, Pasolini non può fare a meno di narrare in Poeta delle Ceneri. Così come non può esimersi dal descrivere il terrore, simile a «quello che può provare un negro a Chicago», riversatogli addosso da una borghesia ignorante, forcaiola, razzista e transazionale: «la borghesia italiana intorno a me è una torma di assassini./ Non spero certo migliore accoglienza dalla borghesia americana.» (Pasolini 2003, vol. II: 1269)
Di questo senso di esclusione, precedente anche alla consapevolezza della propria diversità, Pasolini non può fare a meno di narrare in Poeta delle Ceneri. Così come non può esimersi dal descrivere il terrore, simile a «quello che può provare un negro a Chicago», riversatogli addosso da una borghesia ignorante, forcaiola, razzista e transazionale: «la borghesia italiana intorno a me è una torma di assassini./ Non spero certo migliore accoglienza dalla borghesia americana.» (Pasolini 2003, vol. II: 1269)
Il rapporto tra Pasolini e la borghesia - che più che una classe sociale rappresenta un atteggiamento dello spirito, anzi una vera e propria «malattia contagiosa» (Pasolini 1992a: 460) - ricalca il contrastato legame che il poeta visse con il padre Carlo Alberto: ufficiale di fanteria e convinto sostenitore del fascismo, oltre che uomo smodatamente fiero delle antiche tradizioni familiari e sociali tipiche del suo status (Siciliano 2005: 34-36). Rifiutando il mondo borghese cui apparteneva per nascita, Pasolini spiega di aver voluto, in principio inconsciamente, respingere il fascismo, lo sterile tradizionalismo conformista della «società dei padri» - e di quel padre che sembrava essere la summa di tutti i padri -; delegittimando alla radice quelle regole sociali la cui infrazione relegava in maniera definitiva tra i diversi, tra i segnati (Pasolini 1992b: 32-34).
Anche la dedica al genitore delle Poesie a Casarsa, in parte figlia - sostiene il poeta - del suo ingenuo conformismo di ventenne, era in realtà una prima, ma già pronunciata presa di distanza dal padre; da quell’uomo «prepotente, egoista, egocentrico tirannico ed autoritario» (ibid.: 28). Quest’ultimo del resto, benché orgoglioso della carriera letteraria intrapresa dal figlio, non poteva accettare di buon grado l’uso di un dialetto, il friulano, che non rispecchiava la sua datata concezione del mestiere di scrittore. Che non era nemmeno la lingua parlata in casa - se non altro perché essa non apparteneva alle sue nobili origini ravennati né alle abitudini della moglie che parlava veneto -; e che, soprattutto, era una di quelle lingue particolari che la politica culturale del fascismo disprezzava e intendeva abolire. (ibid.: 28-29).
Il rifiuto della cultura borghese, vero e proprio tradimento che Pasolini sentiva di dover pagare in prima persona (Pasolini 1975a: 52), divenne ancora più palese con la decisione di schierarsi al fianco dei contadini e dei proletari durante le lotte per le occupazioni delle terre che infiammarono l’Italia già nei primi mesi del secondo dopoguerra. Una scelta di cui diversi esperimenti narrativi sfociati poi, attraverso complesse rielaborazioni avvenute a più riprese, in un romanzo - Il sogno di una cosa - in cui il dato autobiografico è altresì evidente, offrono una puntuale testimonianza (Pasolini 1962a). Decisione ancora più travagliata e psicologicamente complessa di quanto non appaia in prima battuta, se solo si tiene presente l’anticomunismo viscerale del genitore e, cosa ancora più importante, che l’amato fratello Guido, militante del Partito d’Azione, era caduto in battaglia proprio per mano dei comunisti sloveni durante uno scontro tra opposte brigate partigiane (Siciliano 2005: 95-107). Ad alimentare i contrasti tra padre e figlio si aggiungerà, di lì a breve, il progressivo rivelarsi di un’omosessualità sempre più malamente nascosta; anch’essa peraltro riversata negli scritti del periodo, i quali mescolano a pagine del diario che lo scrittore aveva cominciato a tenere, dissimulazioni romanzesche in cui l’io dell’autore si sdoppia in personaggi che, tra riscritture, varianti, passaggi dalla prima alla terza persona e viceversa, progetti di prefazione e slittamenti vari, rivivono le gioie, gli amori, le speranze, ma anche le lacerazioni e i tormenti della penna che li ha creati (Pasolini 1998, vol. I: 5-336).
 |
| Il padre di Pasolini, Carlo Alberto, militare di carriera |
L’autore in precedenza aveva registrato anche poeticamente - ne La scoperta di Marx (1949), una delle sezioni de L’usignolo della chiesa cattolica- tale decisivo passaggio rivolgendosi ancora una volta alla madre. E lo aveva fatto come se si fosse trattato di una vera e propria nascita che in sé, come ogni momento di passaggio, portava già i segni del trauma che sarebbe seguito all’uscita da quel grembo sconfinato dentro il quale aveva continuato sino ad allora a vivere. Un trauma che la precoce espulsione dal partito comunista a seguito del conclamarsi della sua omosessualità avrebbe caricato di nuove amarezze, accrescendo il suo senso d’isolamento e la sensazione di vivere come in esilio. «Non pensavi che il mondo/ di cui sono figlio/ cieco e innamorato // non fosse un giocondo/ possesso di tuo figlio,/ […] ma un’antica/ terra altrui che alla vita/ dà l’ansia dell’esilio?// […] Ma c’è nell’esistenza/ qualcos’altro che amore/ per il proprio destino [...] la nostra storia! Morsa/ di puro amore, forza, razionale e divina.» (Pasolini 2003, vol. I, 499-503).
Già a metà degli anni cinquanta - come puntualmente rivelano Le ceneri di Gramsci (Pasolini 1957) e quello straordinario diario di una crisi che è La religione del mio tempo (Pasolini 1961a) - il progressivo affermarsi della società dei consumi e il rivelarsi del volto ferocemente autoritario del comunismo sovietico, contribuiscono a mutare, quella che era sin dall’origine una timida speranza, nella dura consapevolezza di essere l’inascoltato testimone dell’alba, non di un nuovo corso della storia, ma al contrario di una nuova ed eterna preistoria. Un’epoca in cui anche l’umanità più cara, il mondo contadino e il sottoproletariato delle borgate conosciuto a Roma, si apprestava a farsi rapidamente irriconoscibile cedendo alle lusinghe corruttrici del neocapitalismo.
Così, nell’aprile del 1960, mentre l’Italia è nel pieno delle febbrili dinamiche del boom economico che ne avrebbe mutato in breve tempo il volto e i costumi, Pasolini pubblica le Poesie incivili: cinque liriche incluse ne La religione del mio tempo in cui, tra rievocazioni, rimpianti e delusioni, il poeta descrive il movimento che presto lo avrebbe condotto a collocarsi al di là di una società che a sua volta lo spingeva con veemenza tra i reietti, i diversi, gli sconfitti; seppure, come si è visto, soltanto per una «casuale coincidenza,/ confusione d’incoscienza e di coscienza» ( Pasolini 1961, ora in Id. 2003, vol. I: 1046). I valori resistenziali di uguaglianza libertà e giustizia sociale, che egli aveva abbracciato con slancio e sognante passione, potevano ormai sopravvivere solo come una debole luce morale il cui flebile riflesso non faceva che riaccendere le dolorose ferite di una vita sempre più segnata da conflitti irrisolvibili: quelli tra lo spirito e la carne, tra la razionalità e l’irrazionalità, tra la modernità e la tradizione, tra il sé e un mondo ormai lontano, forse già definitivamente perduto.
Tra le Poesie incivili spicca lo splendido Frammento alla morte: quasi un testamento culturale vergato nel momento in cui la presenza della morte, che sempre fa da sfondo a ogni pagina pasoliniana, pare allungare la sua ombra familiare su una stagione della vita, anche di quella letteraria, giunta alla sua funerea conclusione; lasciando all’appassionata invocazione finale, in cui sono palesi gli echi rimbaudiani, il compito di indicare al lettore un nuovo punto di fuga dall’angoscioso presente. Una direzione da esplorare come se si trattasse dell’estrema possibilità di ricomporre i dissidi che assediavano il poeta. «Ho avuto tutto quello che volevo, ormai:/ sono anzi andato anche più in là/ di certe speranze del mondo: svuotato, […] Sono stato razionale e sono stato/ irrazionale: fino in fondo./ E ora…ah, il deserto assordato/ dal vento, lo stupendo e immondo/ sole dell’Africa che illumina il mondo.// Africa! Unica mia/ alternativa…» (Pasolini1961, ora in Id. 2003, vol. I: 1049-1050).
Così, forse obbedendo al disperato slancio con cui si chiude Frammento alla morte, Pasolini raggiunge per la prima volta un paese africano, il Kenya, nel febbraio del 1961. Dal mese precedente ha lasciato l’Italia in compagnia di Alberto Moravia, e più tardi di Elsa Morante che li raggiunse a metà del viaggio, per recarsi dapprima in India, terra a cui dedicherà un fortunato volumetto, tuttora ristampato con successo, che raccoglie una serie di articoli sotto forma di racconto pubblicati sul quotidiano «Il Giorno» (Pasolini 1962b); e poi, evidentemente stimolato da un’esperienza di cui si affanna a raccogliere e restituire «l’odore», verso il continente nero, che in quel periodo era tutto un ribollire di lotte per l’indipendenza e di guerre civili. Nello stesso anno scrive anche un’originale prefazione, oggi quasi dimenticata, per un’antologia di poeti di origine africana: un testo che aiuta a comprendere come l’Africa che più tardi avrebbe rappresentato nelle sue opere sia una realtà percepita proprio come l’ideale prosecuzione, o meglio la vera e propria riattualizzazione, di un sogno sorto direttamente dal cuore della lunga notte nazifascista.
Il titolo dello scritto, La resistenza negra (Pasolini 1961b; ora in Id. 1999, vol. II: 2344-2355), da solo è già sufficiente a richiamare il lettore sul senso e sul valore che le esperienze testimoniate dalle liriche incluse nell’antologia resuscitano nell’animo del poeta friulano. Nell’incipit egli rende ancora più diretto il riferimento al proprio passato sostenendo che la prima impressione che si ricava leggendo i versi antologizzati a cura di M. De Andrade è quella di una lettura «un po’ antiquata», come se fossero stati scritti una decina di anni prima, ovvero all’inizio di quegli anni cinquanta che, dopo le prime e più difficili fasi della ricostruzione post-bellica, avrebbero dovuto coincidere con l’affermazione di quella giustizia sociale che in molti ritenevano essere il vero lascito di una intensa stagione di lotta a cui a suo modo, come si vedrà a breve, anche il poeta aveva consegnato il suo piccolo ma importante contributo. È opportuno sottolineare come per il poeta non sia solo questa particolare affinità con un passato, certamente romanticizzato, a rendere quelle liriche degne di essere presentate a un pubblico apparentemente distante. E ciò per il fatto che il «sapore della Resistenza» sprigionato dalle parole dei poeti neri è «un sapore estremamente significante, non solo per il rimpianto, […] non solo per quel tanto di poeticità oggettiva che c’è in esso, non solo: perché la Resistenza negra non è finita; e pare non debba finire com’è finita qui da noi.» (ibid: 2344)
Interessante è pure la distinzione che Pasolini introduce immediatamente dopo, ovvero quella che oppone l’idea di «Resistenza»: vero e proprio valore culturale reso graficamente con l’utilizzo della prima lettera maiuscola; a quella di resistenza intesa invece come una particolare esperienza storica che in Europa secondo l’autore si era chiusa, una decina di anni prima appunto, con la chiara sconfitta delle istanze di rinnovamento di cui essa era portatrice. In tal modo, scrive Pasolini, «se per noi Resistenza equivale, ancora, a speranza, la resistenza storica […] è ormai senza speranza»; mentre al contrario «in Africa, è chiaro, non è avvenuta la scissione di resistenza e Resistenza. Si lotta dappertutto» (ibid.).
In questo senso lo scritto in questione testimonia il progressivo rivelarsi agli occhi del poeta del nuovo terreno in cui, forse troppo ingenuamente, egli sperava di poter riannodare i fili del proprio tempo perduto, riprendendo quel cammino che in Occidente era stato fatalmente interrotto, se non contraddetto, dall’avvento della società dei consumi da un lato, e della dittatura sovietica dall’altro: poli di una falsa dialettica che il poeta ricondurrà presto alla medesima matrice culturale. (Arecco 1972: 75). Un’esigenza esistenziale, ancor prima che politica o sociale, nella quale Pasolini avrebbe investito gran parte del proprio talento. Da quel primo viaggio africano in effetti, lo scrittore riceverà lo stimolo per pensare a opere che diano una nuova prospettiva ai suoi antichi tormenti; riallacciando al presente e al futuro un passato la cui luce era giunta sul punto di smarrirsi: quella «pura luce» della resistenza cui ora poteva forse sostituirsi la fiaccola ardente de «la negra luce».
La poesia di Pier Paolo Pasolini, i dipinti
di Pellizza da Volpedo, la musica di Ennio Morricone...
Di quell’alba primigenia che sembrava schiudersi a suoi occhi di ragazzo, e che Pasolini ricerca ora in Africa, l’autore aveva narrato nella sesta sezione de La Religione del mio tempo; quella in cui, prendendo a pretesto una nuova proiezione di «Roma città aperta» di Rossellini alla quale casualmente gli era capitato di assistere «deciso a tremare nel ricordo» (Pasolini 1961a, ora in Id. 2003, vol. I: 937), il poeta rievoca quella che definisce la sua «educazione sentimentale». Una luce che era «speranza di giustizia:/ non sapevo quale: la Giustizia. La luce è sempre uguale ad altra luce./ Poi variò: da luce diventò incerta alba,/ […] Illuminava i braccianti che lottavano./ Così l’alba nascente fu una luce/ fuori dall’eternità dello stile…/ Nella storia la giustizia fu coscienza/ d’una umana divisione di ricchezza,/ e la speranza ebbe nuova luce.» (ibid.: 944-955). La potenza delle immagini proiettate sembra per un attimo ricreare la forza eroica di quei tempi, eppure Pasolini, «nella platea di oggi», mescolato tra ragazzi nei cui occhi non c’è più la luce del futuro, sente di avere «come una serpe/ nei visceri, che si torce: e mille lacrime» causate dalla chiara sensazione «di sapere che tutta quella luce,/ per cui vivemmo, fu soltanto un sogno/ ingiustificato, inoggettivo, fonte/ ora di solitarie, vergognose lacrime.» (ibid.: 946-947).
Il rapporto di Pasolini con la resistenza negli anni è stato oggetto di frequenti discussioni, suffragate anche da alcune dichiarazioni in cui il poeta lasciava intendere di avervi materialmente partecipato (Pasolini 1992b: 33). In realtà il suo impegno politico in quegli anni terribili, ma anche dopo il conflitto fatta eccezione per una breve stagione, fu interamente rivolto alla sfera intellettuale; in nome di un antifascismo culturale che era nato in lui in maniera spontanea sin da quando iniziò «a leggere autori come Dostoevskij e Shakespeare, e poi poeti come Rimbaud e gli ermetici, esponenti di una cultura che il regime disapprovava e respingeva»; tanto che fu proprio da allora che iniziò a percepirsi come «al di fuori della società» (ibid.: 32). È interessante in proposito scorrere anche la nutrita corrispondenza che Pasolini intrattenne con amici e confidenti sin dal 1940 - quando si trovava ancora a Bologna per frequentare l’università e il trasferimento dell’amico Farolfi a Parma gli offrì l’occasione per una prima e fitta corrispondenza che in seguito avrebbe esteso a molti altri «compagni di viaggio» - esponendo sentimenti, principi di poetica generale e l’evoluzione del proprio malessere, in maniera ancora più nitida che nelle interviste (Pasolini 1986; Id. 1988, due volumi entrambi curati da N. Naldini).
All’amico Luciano Serra nel 1943, a breve distanza di tempo dalla caduta del regime mussoliniano, quando in nord Italia era già iniziata la fase più cruenta della guerra civile e lo scrittore con la sua famiglia aveva riparato in Friuli, Pasolini scrive una lunga e articolata lettera in cui non mancano espressioni di dubbio e di perplessità circa la via giusta da intraprendere per risollevare un paese sull’orlo del baratro; indicando tuttavia in maniera precisa le coordinate di quello che sarebbe stato il suo impegno di intellettuale: «L’Italia ha bisogno di rifarsi completamente, ab imo, e per questo ha bisogno, ma estremo, di noi, che nella spaventosa ineducazione della gioventù ex-fascista, siamo una minoranza discretamente preparata. […] Noi abbiamo una vera missione, in questa spaventosa miseria italiana, una missione non di potenza o di ricchezza, ma di educazione, di civiltà.» (Pasolini 1986: 181-185).
Una missione di educazione e di civiltà è, ad esempio, quella sorta dalla decisione, presa proprio in quel periodo, di mettere su, nei dintorni di Casarsa, una piccola scuola gratuita per i figli dei contadini che, con l’intensificarsi dei bombardamenti alleati, non potevano più raggiungere Udine o Pordenone. Iniziativa alla quale Pasolini associò sua madre e alcuni amici, tra i quali la poetessa Giovanna Bemporad che raggiunse appositamente il paesino friulano da Bologna. Sarà un’esperienza decisiva per il poeta che la vivrà con entusiasmo e dedizione, tanto che anche dopo l’ordine di chiusura immediata sollecitato dal Provveditorato agli studi di Udine, Pasolini continuò imperterrito a impartire «ai suoi ragazzi» lezioni appassionate di letteratura greca, italiana, di grammatica, di latino. Il metodo anticonvenzionale utilizzato dal giovane insegnante risultava estremamente stimolante per i giovani allievi che venivano anche incoraggiati a comporre poesie in lingua e in dialetto, ovvero ad appropriarsi poeticamente della lingua, della realtà, e dei luoghi in cui vivevano imparando così ad esprimersi. (Villa e Capitani 2005). Per uno di quei ragazzi, Tonuti Spagnol, Pasolini provò anche un violento e contrastato sentimento di amore che ne fece il dichiarato ispiratore del racconto giovanile Atti Impuri (Pasolini 1982). Quello che è indubbio è che il ragazzo divenne rapidamente il suo allievo prediletto (Siciliano 2005: 98), quello che il maestro più incoraggiava a comporre rime e versi, alcuni dei quali trovarono anche spazio, e una piccola nota di commento, nel saggio La poesia dialettale del novecento. (ora in Pasolini 1960: 134).
Dopo la piccola ma decisiva esperienza didattica, nell’immediato dopoguerra, Pasolini sarebbe divenuto insegnante a tutti gli effetti presso una scuola media statale distante da casa sua una dozzina di chilometri che ogni giorno percorreva in bicicletta (Siciliano 2005: 128-131). Nello stesso periodo lo scrittore non mancherà di pubblicare, su alcuni giornali locali, diversi articoli riguardanti le sue riflessioni sul ruolo che la scuola poteva e doveva svolgere in quel periodo caratterizzato da una grande miseria, ma da un altrettanto grande desiderio di rinascita (ora in Pasolini 1993: 269-283). Testi come Poesia nella scuola, Dal diario di un insegnanteo come Scuola senza feticci: in cui l’innovativo, per quei tempi, disegno pedagogico dello scrittore di dar vita a una tradizione non feticistica, ma al contrario quasi da reinventare ex-novo, è formulato in questi termini: «come suscitare nel ragazzo il gusto della critica e provocare la caduta degli idoli? Evidentemente immettendolo in un clima di scandalo e di incertezza, in cui le cose eterne non siano quelle imparate a memoria, ma quelle che più somigliano alle vocazioni che sono in lui [...] Del resto in tal modo resta delineato lo scopo dell’educazione che è creazione di una cultura». (ibid.: 279)
Tali considerazioni, così come le esperienze pedagogiche e politiche da cui sorgevano, non potevano, alla luce di quanto sostenuto sinora, non confluire negli scritti più specificamente narrativi. È di quegli anni un abbozzo di un breve romanzo - rimasto a lungo inedito e poi pubblicato a cura del cugino materno di Pasolini con il titolo di Romàns - che ha come protagonisti un sacerdote assediato dalle inquietudini derivate da un’omosessualità che tenta disordinatamente di sublimare nella fede e nell’azione pastorale, e un giovane intellettuale divenuto comunista ma di estrazione piccolo borghese. Il primo, Don Paolo il suo nome, apre un piccolo doposcuola per i figli dei contadini del circondario; mentre il secondo, Renato, insegna in una scuola pubblica. Tra i due s’instaura molto presto un rapporto molto particolare, ricco di reciproci scambi di vedute sulle rispettive esperienze, ed è sin troppo facile scoprire nei due personaggi la viva voce dell’autore e delle sue coeve vicende private. (Pasolini 1994, ora in Id. 1998, vol. II: 197–263)
L’originario e contrastato sentimento religioso ricco di accenti sacrificali e misticheggianti che aveva presieduto alle prime prove poetiche, l’omosessualità ancora taciuta - vissuta talvolta come una colpa da espiare oppure al contrario come una prepotente inclinazione alla quale non si può che obbedire -; la peccaminosa eppure pura attrazione per uno dei ragazzi che frequentava le sue lezioni, l’impegno a fianco dei contadini in virtù di posizioni vagamente socialiste e cristiane, l’insegnamento e le prime polemiche letterarie e politiche, rappresentano gli estremi entro i quali era racchiuso il senso stesso di una vita. Ed essi, pur rivivendo in due distinti personaggi, riescono effettivamente a saldarsi nello spazio letterario di un racconto in cui quasi in ogni passo è possibile scorgere in controluce gli accadimenti e le peripezie che coinvolgevano l’allora giovane autore.
 |
| Pasolini in Africa per la lavorazione di "Appunti per un'Orestiade africana" |
L’attore del dramma è dunque un ragazzo che metaforicamente incarna il desiderio di rinascita del popolo africano, la voglia di dare vita a una civiltà che sappia raccogliere alcuni elementi della modernità importata dal dominatore coloniale, integrandoli criticamente a una tradizione che non poteva più sopravvivere così come era stata nell’«epoca dei padri». «L’altro polo del dramma è suo padre: un uomo antico, selvaggio nel senso nobile della parola. Il film si chiamerà appunto Il padre selvaggio» (ibid.).
Proseguendo nell’intervista il regista rivela che il suo produttore, Alfredo Bini, aveva in mente per il film un titolo ritenuto forse più suggestivo, ovvero È bello uccidere il leone; o addirittura un altro, Il sogno di una cosa, che ancor di più rivela la decisa corrispondenza delle tematiche che avrebbero dovuto costituire il nucleo dell’opera in questione, con quelle a cui lo scrittore si era dedicato sin dalla giovinezza. Nell’estate dello stesso anno Pasolini decise di pubblicare quello che nell’intervista a Biamonte definisce «soggettino», e per l’occasione utilizzerà proprio il primo dei titoli propostogli dall’amico produttore (Pasolini 1962c, ora in Id. 2001, vol. I: 317-325). Si tratta di un breve scritto articolato in quattro piccoli capitoli, ciascuno provvisto di un titolo, in cui inizia a prendere forma la vicenda di un insegnante europeo dalle idee progressiste che deve faticare non poco per liberare la sua intimidita scolaresca dagli impacci tipici di una cultura assorbita acriticamente grazie all’opera dei solerti insegnanti coloniali che lo avevano preceduto (ibid.: 317).
Pare che per la costruzione del suo personaggio Pasolini si sia in parte ispirato alla vicenda di un giovane insegnante francese che aveva narrato la sua esperienza tra i banchi di una scuola della Guinea a Yves Benot; il quale ne aveva tratto spunto per un articolo giornalistico, poi ritrovato tra la carte del regista, intitolato Tre anni di insegnamento a Conakry. Le affinità tra la storia narrata nell’articolo dall’insegnante, e quella scritta dal regista friulano sono evidenti, tuttavia il racconto pasoliniano sarà ambientato non in Guinea ma in Congo, più precisamente nel Congo travolto dalla ferocia della guerra civile che, appena dopo la raggiunta indipendenza, oppose le forze secessioniste della regione del Katanga, guidate da Ciombé e sostenute dagli interessi minerari europei, al governo centrale di Lumumba che nella sua battaglia ottenne anche l’appoggio di contingenti militari dell’Onu. Un’importante differenza che consente a Pasolini di inserire la sua vicenda in un quadro che ne esalti quel carattere tragico che sempre alimenta le sue opere; utilizzando come ulteriore punto di riferimento per la tessitura dell’intreccio anche molto del suo personale bagaglio di insegnante attivo proprio negli anni in cui anche l’Italia era precipitata in una sanguinosa guerra civile.
Non è del resto difficile scorgere Pasolini stesso dietro il personaggio del «professore democratico» alle prese con una «lotta al conformismo insegnato ai ragazzi dai precedenti professori colonialisti» (ibid.), così come nella vita aveva cercato di fare con i figli dei contadini friulani, invitandoli ad abbattere i feticci culturali in nome di un sapere concepito più come una creazione che come la perpetuazione di una cultura tramandata dagli antenati. Una lotta che lo porta a scontrarsi con il più intelligente dei suoi scolari: un ragazzo di nome Davidson che sin da subito manifesta un’aperta ostilità nei confronti dei nuovi metodi dell’insegnante. Le aperture democratiche del professore creano, in effetti, un certo disagio nella classe: fino ad allora abituata a riprodurre quasi meccanicamente quanto ascoltato durante le lezioni, lasciandolo peraltro separato dalle antiche consuetudini tribali divenute ormai per loro altrettanto meccaniche. I problemi si concretizzano con maggior evidenza il giorno in cui l’insegnante assegna un tema in cui i ragazzi avrebbero dovuto narrare la propria vita in seno alla tribù da cui provenivano. «Egli vuole che i suoi scolari affrontino coraggiosamente la vergogna, la miseria, la superstizione dello stato tribale da cui provengono. Cerca di spiegare loro che cosa è la cultura preistorica o magica, […] ormai superata dalla storia degli stessi africani» (ibid.: 318); ma deve constatare con amarezza come i suoi allievi si limitino a utilizzare solo una serie di stereotipi di importazione coloniale ritenuti evidentemente adeguati a soddisfare le curiosità del loro maestro.
Saranno invece necessarie tre o quattro riscritture prima di ottenere, da parte di Davidson naturalmente, un elaborato in cui con originalità era narrata un’antica usanza della tribù in cui ancora viveva suo padre, secondo la quale ogni giovane per essere considerato adulto doveva uccidere, da solo, un leone. L’insegnante dopo aver pubblicamente elogiato l’allievo spiega alla classe che ormai tali riti avevano perso il loro valore; ricordando loro che il nuovo futuro dell’Africa doveva essere costruito alla luce della consapevolezza della sua drammatica situazione. La cultura africana non poteva ridursi a una sterile, e ormai svuotata, riproposizione della «cultura paterna»; ma doveva continuare a svilupparsi soprattutto grazie ai nuovi miti poetici creati dai poeti neri contemporanei; i quali veicolavano contenuti più idonei alle condizioni contingenti. Proprio quei poeti che la scolaresca si ostinava a non voler comprendere, nemmeno quando il professore spiegava pazientemente le immagini poetiche procedendo passo per passo con il suo ragionamento.
Saranno invece necessarie tre o quattro riscritture prima di ottenere, da parte di Davidson naturalmente, un elaborato in cui con originalità era narrata un’antica usanza della tribù in cui ancora viveva suo padre, secondo la quale ogni giovane per essere considerato adulto doveva uccidere, da solo, un leone. L’insegnante dopo aver pubblicamente elogiato l’allievo spiega alla classe che ormai tali riti avevano perso il loro valore; ricordando loro che il nuovo futuro dell’Africa doveva essere costruito alla luce della consapevolezza della sua drammatica situazione. La cultura africana non poteva ridursi a una sterile, e ormai svuotata, riproposizione della «cultura paterna»; ma doveva continuare a svilupparsi soprattutto grazie ai nuovi miti poetici creati dai poeti neri contemporanei; i quali veicolavano contenuti più idonei alle condizioni contingenti. Proprio quei poeti che la scolaresca si ostinava a non voler comprendere, nemmeno quando il professore spiegava pazientemente le immagini poetiche procedendo passo per passo con il suo ragionamento.
Ciò nonostante sarà proprio Davidson a rispondere al professore che nonostante lui comprendesse il significato di quella lezione, non poteva fare a meno di concludere dicendo che «è bello uccidere il leone!...» (ibid.) Inizialmente disorientato l’insegnante cerca allora di spiegare che «sì, è difficile staccarsi criticamente dal proprio mondo vitale»; tuttavia esso ormai è poco più che un relitto che dà luogo soltanto a una «vitalità istintiva che è la sede poi, a un livello superiore, della pigrizia intellettuale, e del conformismo» (ibid.). Tale ostinato ripiegamento nel passato e nel tradizionalismo cieco non produceva insomma un nuovo presente; ma più semplicemente una irrazionale quanto pericolosa autoreclusione nel circolo vizioso di una creazione culturale di cui risultavano ormai svelati i limiti.
Nel frattempo giunge la fine dell’anno scolastico e con essa le vacanze che Davidson trascorre facendo ritorno alla sua tribù riunita in un villaggio situato nel centro della foresta. Nel corso dell’anno, dopo i primi contrasti, il ragazzo ha avuto modo di stringere amicizia con il suo giovane insegnante, tanto che un po’ della nuova cultura impartitagli dal maestro, e che l’autore definisce «storica», è divenuta parte integrante della sua personalità. Nel terzo capitoletto del soggetto in questione, La negra luce, Pasolini avrebbe voluto rappresentare il ritorno a casa di Davidson facendo in modo che le immagini e i gesti, più che le parole, rendessero concretamente l’idea della vita tribale. «Ora nei momenti di tranquillità, di normalità, la sua cultura storica, europea, potrebbe diffondersi nella sua famiglia, nei suoi coetanei del villaggio. Ma questo non è un momento di pace. La tribù fa parte di una regione dello stato che ha proclamato la propria indipendenza. E si è giunti, nella foresta, a una vera e propria guerra. E la guerra, col suo terrore, la sua contagiosa sete di uccidere, non può essere che regressiva: in essa tutto ciò che è storico, e civile, pare dissolversi, ridursi a puro meccanismo» (ibid.: 321-322). Lentamente il villaggio di Davidson diventa il centro di un inutile massacro che vede contrapposte la tribù di suo padre, alcune legioni di bianchi mercenari, e le truppe governative affiancate dall’Onu. Il regista avrebbe voluto inserire a questo punto immagini documentarie che testimoniavano della vita dei combattenti, della durezza degli scontri; mentre sullo sfondo si sarebbe materializzata la «regressione» di Davidson che in nome dell’antico legame ancestrale ripercorreva all’indietro tutto il percorso che lo aveva portato a sognare per il suo paese un futuro da stato democratico moderno.
Culmine di tale ridiscesa è la partecipazione di Davidson a un episodio di cannibalismo in cui, durante un macabro rito celebrato dalla sua tribù, vengono consumati i resti di alcuni caschi blu dell’Onu con i quali, tra l’altro, prima di partire il giovane aveva avuto modo di fraternizzare e di scambiare opinioni sulle donne, sulla musica, sulla poesia. Proprio perché ormai inautentico però, tale ritorno indietro verso un passato tanto distante quanto diverso dalla nuova realtà che le lezioni del professore avevano aperto agli occhi del ragazzo, si trasforma in uno stato di catatonia che lo invade senza che egli possa fare nulla per distrarsene. Se la guerra, con i suoi moderni congegni mortali, si era rivelata un’inutile barbarie, allo stesso modo l’artificioso regresso verso un rito ormai disarticolato dal tessuto sociale della sua antica tribù non poteva più aprire spazi di operatività futura, ma al massimo riprodurre per altra via le stesse furiose meccaniche tipiche della carneficina militaresca.
Così, all’inizio del nuovo anno scolastico, l’insegnante avrebbe dovuto ben presto accorgersi che lo studente in cui aveva riposto il grosso delle sue speranze di riuscita versava in uno stato di semicoscienza che lo vedeva svolgere in modo automatico i compiti che gli venivano impartiti, come se vivesse ormai al di fuori sia del presente rappresentato dagli ideali democratici dell’insegnante, che dal passato incarnato dalla sua antica vita tribale. L’insegnante cerca di aiutare il ragazzo a vincere la sua nevrosi: gli parla, gli spiega razionalmente il senso della sua vicenda, arriva addirittura a seguirlo per spiare i suoi comportamenti al di fuori degli orari scolastici. Sarà però un evento occasionale a permettere il superamento della crisi in cui il ragazzo sembrava perduto. «Forse il miracolo avviene casualmente. Talvolta la nevrosi crea in sé la guarigione…Può apparire un Dio, un'immagine sacra… Ma anche un fantasma di altro ordine…» (ibid.: 324)
Per la precisione avviene che l’insegnante un giorno legge una poesia di un poeta nero contemporaneo che l’anno prima la classe proprio non aveva voluto comprendere. Sorprendentemente stavolta tutti sembrano coglierne il senso e lo stesso Davidson, all’improvviso, pare riaccendersi in un moto di vita. Il professore se ne accorge e legge con ancora più enfasi la lirica, anche se la luce che per un attimo aveva di nuovo illuminato lo sguardo del ragazzo improvvisamente torna ad affievolirsi, senza però sparire del tutto. Finita la lezione Davidson va come al solito a sedersi in cortile, dove viene però raggiunto da una poetica voce interiore che gli detta dei versi che il ragazzo inizia dapprima a ripetere a voce sempre più alta, per poi correre nella camerata a riversarli su un foglio che avrebbe prontamente consegnato al suo insegnante. «Sono versi tremendi, di totale disperazione, di morte: non solo la sua, di Davidson, ma dell’intera razza negra.» (ibid.)
Sono però versi bellissimi che il professore farà addirittura pubblicare, così come Pasolini aveva fatto pubblicare quelli del suo Tonuti, su una rivista europea. Davidson scopre così nella poesia la via privilegiata per sciogliere la propria crisi interiore; una via in cui il suo antico retroterra culturale poteva contribuire a dare vita a quella felice sintesi che, secondo il suo insegnante, sarebbe dovuta essere la cultura africana moderna. Del resto «esprimersi significa guarire. Non importa se l’espressione è confusa, e se la speranza in fondo all’espressione è solo il sogno di una cosa». Nuovi versi, stavolta meno cupi, sarebbero giunti a nutrire la sua rinnovata speranza verso «un futuro confuso ma felice, al cui pensiero, un leggero sorriso può biancheggiare nel fosco viso del ragazzo negro.» (ibid.: 325)
Pier Paolo Pasolini avrebbe continuato a lavorare all’originario soggetto ricavandone un’affascinante sceneggiatura in cui, con evidenza ancora maggiore, i tratti autobiografici dell’autore s’inseriscono nel tessuto di un racconto che non divenne mai film. Nell’anno della sua morte, seguendo quella logica che lo vedeva consegnare alle stampe anche i suoi «sentieri interrotti», Pasolini decise di pubblicare il testo corredandolo di una nota e di una poesia in cui si spiegavano le ragioni per le quali la pellicola non avrebbe mai visto la luce. (Pasolini 1975b). Si tratta ancora una volta di una mescolanza di fatti pubblici che causano un dolore privato che a sua volta ridiviene pubblico per il semplice fatto di essere esteriorizzato all’interno di un’opera: «È stato il processo alla Ricotta, per vilipendio alla religione, che mi ha impedito di realizzare Il padre selvaggio. Il dolore che ne ho avuto - e che ho cercato di esprimere in questi ingenui versi di E l’Africa? - ancora mi brucia dolorosamente. Dedico la sceneggiatura del Padre selvaggio al pubblico ministero del processo e al giudice che mi ha condannato.» (ibid.: 58)
Nei versi di E l’Africa? il poeta ricostruisce un onirico dialogo con il suo produttore, Alfredo Bini, decisamente irato dalla piega che stavano prendendo le cose e dagli intoppi che subiva la casa di produzione. L’uomo simile a un lanzichenecco, «dietro un tavolo, di gusto rustico,/ per grandi burocrati,/ mi fissava coi suoi occhi azzurri ma classici/ mentre fuori scoppiavano le bombe atomiche […] poi cominciò […] a rimproverarmi, a darmi del pazzo…/ E io innocente, offeso…ascoltavo,/ rimescolando nella gola di adolescente vestito/ dalla madre/ lacrime e rimostranze» (ibid.: 59). Poi all’improvviso, come a chiudere i contorni di un quadro i cui primi tratti, come si è visto, erano stati tracciati negli anni della giovinezza in Friuli, il volto rossiccio dell’uomo pare sdoppiarsi fino a farsi altro. «E io ero un po’ sollevato./ Ma quell’altro, lì, che per osmosi/ era uscito dal costato di Bini, era mio padre. […] mi avvicinai a lui, e timidamente quasi sul suo viso…/ che ormai era solo il viso di mio padre,/ con la sua pelle grigia di ubriaco e di morente,/ gli sussurrai: E… L’Africa?/ E i flamboyants di Mombasa?/ I rami rossi, contro il fogliame verde, […] senza di cui la mia anima non poteva più vivere?/ […] Ah, padre ormai non mio, padre nient’altro che padre,/ che vai e vieni nei sogni,/ […] presentandoti a dire cose terribili,/ a ristabilire vecchie verità,/ […] Il mondo è la realtà che tu hai sempre paternamente/ voluto./ E io, figlio, a sperimentare sistematicamente tutto,/ […] mi ritrovo qui, prima cavia di un dolore ignoto,/ a prefigurare il caso dell’impossibilità/ «a esprimersi per ragioni di forza maggiore»;/ […] ma in questa grande normalità paterna dei sogni e della/ vita/ dopotutto, com’è commovente,/ il mio voler morire, nel sogno,/ per la delusione di un rosso e d’un verde perduti!» (ibid.: 60-61).
 |
"Pagine corsare", blog dedicato a Pier Paolo Pasolini - Autrice e curatrice: Angela Molteni Autori associati: Alessandro Barbato, Claudio Rampini, Marco Taffi le notizie contenuti in oltre dodicimila documenti dedicati a Pier Paolo Pasolini |